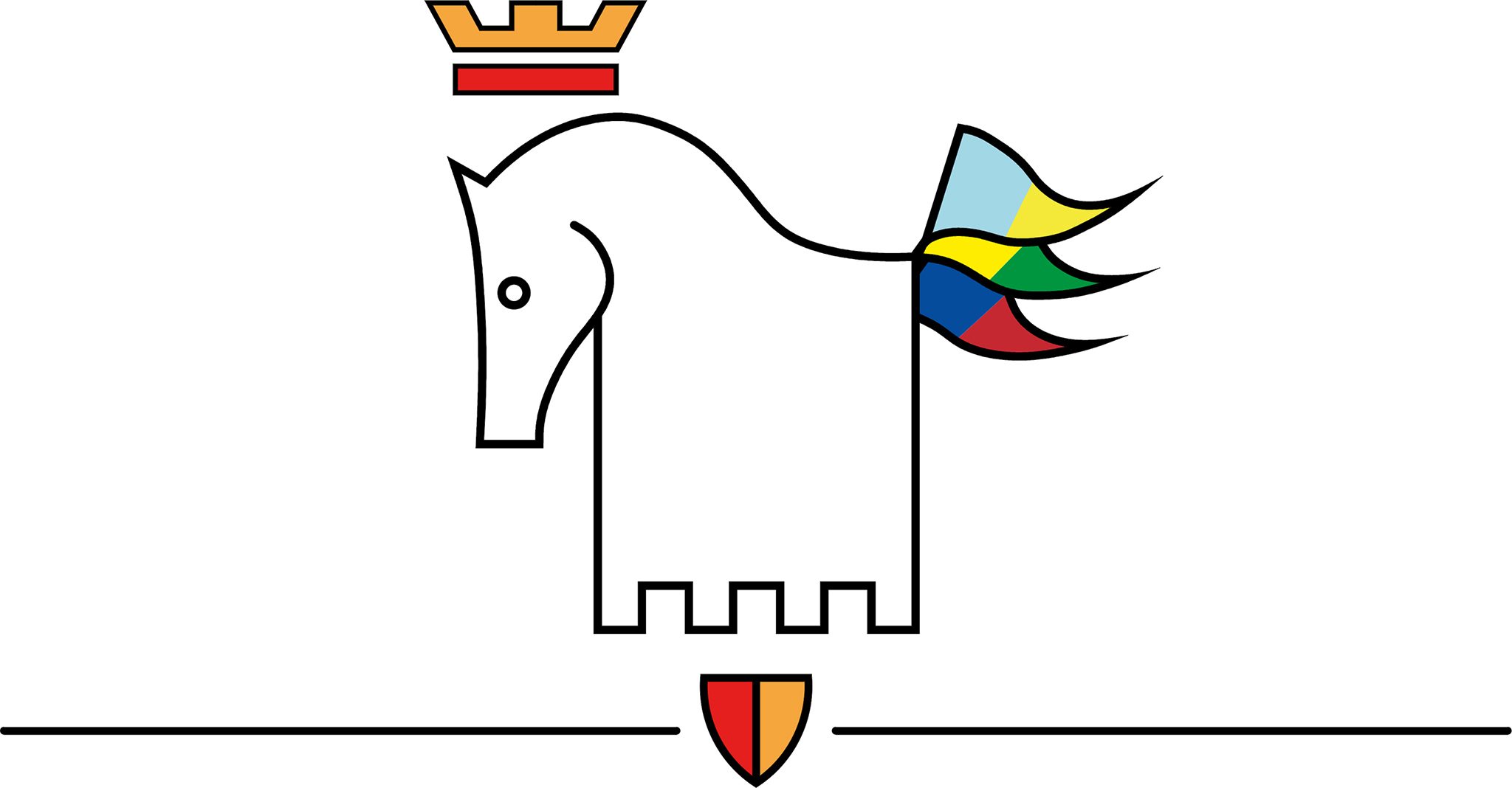la città di cori
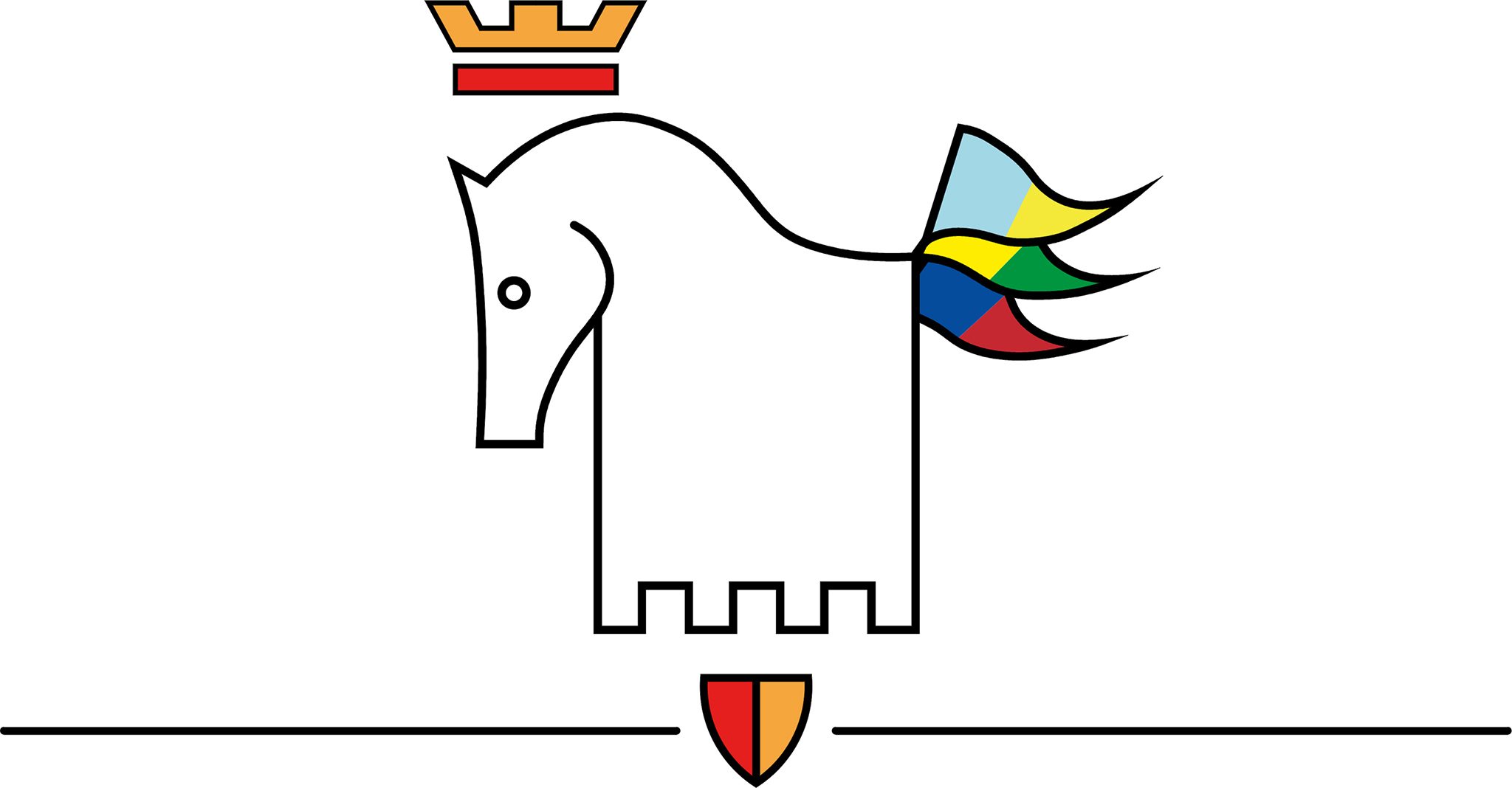
NOTIZIE STORICHE SU CORI

Nemica e poi alleata di Roma nell’antichità, comune sotto la giurisdizione del Senato Romano e della Chiesa nel Medioevo, ma con uno statuto autonomo: Cori ha una lunga storia da raccontare, e lo fa oggi attraverso i suoi muri e monumenti.
Età antica
Secondo diverse leggende, Cori (Cora in origine) fu fondata da Dardano, da Enea o da Corace (che le diede il nome). Quel che è certo è che la sua storia inizia ben prima di Roma. I primi insediamenti risalirebbero al X-IX sec. a.C., nel VII e VI secolo a.C. partecipava attivamente alla politica locale e già a partire dalla fine del VI sec. a.C. aveva una struttura urbana, con mura e terrazzamenti in opera poligonale, importanti aree sacre e santuari.
Fino alla Guerra Sociale del 90-88 a.C. mantenne una larga autonomia politica e amministrativa come città alleata di Roma. Poteva fregiarsi, infatti, della sigla SPQC (Senatus Popolusque Corensis), a dimostrazione che aveva organi decisionali propri. In questo lungo arco di tempo si arricchì di quegli edifici e monumenti (le mura, i templi e il Ponte della Catena) che attrassero l’attenzione di artisti, letterati ed eruditi sin dal Rinascimento.
Il Medioevo
Sull’età tardo-antica e alto-medievale abbiamo solo informazioni frammentarie (probabilmente Cori subì un saccheggio da parte delle truppe di Federico Barbarossa nel 1167), ma le opere architettoniche dell’epoca (quartieri medievali e chiesa di Sant’Oliva) raccontano di una città florida tra XI e XV sec.
In questo periodo è, a fasi alterne, sotto la giurisdizione dello Stato Pontificio o del Senato di Roma, ma conserva una certa autonomia. I suoi Statuti prevedevano infatti che avesse un podestà, tre priori (uno per ogni porta), un consiglio particolare e uno generale e diverse altre figure amministrative. Dal 1512 il podestà, in carica per 6 mesi, era eletto dal Senato di Roma, mentre i priori erano estratti a sorte ogni prima domenica di ottobre, nella chiesa di S. Oliva.
Dal Rinascimento a oggi
Anche nel Rinascimento Cori mantenne larga autonomia come feudo del Senato di Roma, condizione da cui fu affrancata nel 1847. Numerosi gli edifici, i palazzi e i monumenti di questo periodo (tra cui l’Oratorio della SS. Annunziata e il complesso monastico di Sant’Oliva).
Con l’unità d’Italia e la fine dello Stato Pontificio, la città fu annessa prima alla provincia di Roma e quindi a quella di Littoria, oggi Latina.
Fonte: Scoprire Cori
CAPPELLA DELL’ANNUNZIATA
L’oratorio della SS. Annunziata, monumento nazionale, è una perla della pittura quattrocentesca, definita “la cappella degli Scrovegni del basso Lazio”.
Posizione strategica – Salite la scalinata e vi troverete davanti a una piccola meraviglia pittorica, incastonata nel verde come un’oasi nella via trafficata: l’oratorio della SS. Annunziata (Cori), noto anche come cappella della SS. Annunziata. Erroneamente definito come “chiesa”, in realtà era un locale annesso alla chiesa vera e propria, S. Silvestro, dal Seicento dedicata al S. Crocifisso.
Il complesso ora è circondato da abitazioni, ma fino agli anni Cinquanta era in aperta campagna, sulla principale via di accesso a Cori, che collegava la città alla via Appia e a Roma. Nel Medioevo era qui che si fermavano i magistrati provenienti dalla Capitale, e solo dopo aver giurato di rispettare gli statuti coresi erano ammessi entro le mura. Non a caso la chiesa era dedicata a S. Silvestro: proteggere i cittadini dai pericoli della palude vicina era cosa da poco, per un santo che nella vita aveva sconfitto un drago.
Sobria, ma solo all’esterno
La costruzione dell’oratorio iniziò presumibilmente nel secondo decennio del Quattrocento e terminò nei decenni successivi. Il committente fu il cardinale Pedro Fernández de Frías, vicario pontificio e rettore per la Sabina e la provincia di Campagna e Marittina, di cui Cori faceva parte. Ce lo dice l’iscrizione sul portale d’ingresso: “De Spagna fuit qui me legerit dicat unu(m) pater n(oste)r p(ro) a(n)i(m)a mea” (“Fu spagnolo. Chi mi leggerà dica un Padre Nostro per l’anima mia”).
Accanto alla porta, il più antico stemma esistente del Comune di Cori, che partecipò alla costruzione. Il rametto di ulivo sulla mensola sopra l’ingresso è un probabile riferimento a S. Oliva di Anagni, patrona della città.
Gli edifici intorno all’oratorio e alla chiesa – una sagrestia, la cella dell’eremita custode della chiesa, il campanile, un nuovo romitorio – furono aggiunti nel Seicento e nel Settecento, durante lavori di restauro. Affacciandovi al cancello dell’orto degli eremiti, potrete scorgere ancora i resti del romitorio.
Fonte: Scoprire Cori
CHIESA DI SANT’ OLIVA
Una chiesa medievale che ingloba i resti di un antico tempio, una cappella del Quattrocento interamente affrescata, un chiostro rinascimentale e un convento: tutto questo è S. Oliva, 2000 anni di storia racchiusi in una piazza panoramica che sembra uscita dal Medioevo.
S. Oliva: una e molte insieme
Arrivati nella piazza di S. Oliva, non entrate subito. Concedetevi qualche minuto per osservare il piazzale e la facciata imponente della chiesa e del convento, perché qui, in pochi metri quadrati, sono racchiusi 2000 anni di storia. Osservando la facciata, noterete le tracce di vari interventi che si sono succeduti in epoche diverse, archi e colonne incastonati nella parete, edifici non contemporanei tra loro.
In effetti, S. Oliva è un perfetto esempio di come la città di Cori sia cresciuta su se stessa: ogni epoca ha costruito nuovi edifici sulla base dei vecchi, e li ha rimodellati secondo il gusto e le necessità del momento. Per questo S. Oliva si è guadagnata l’appellativo di “complesso monumentale”: in origine, qui sorgeva un tempio romano del III-I sec. a.C.; nella prima metà del XII sec. sulla base del tempio fu costruita una chiesa dedicata a S. Oliva di Anagni; nella seconda metà del XV sec., infine, furono aggiunti la cappella del S. Crocefisso e il convento degli Agostiniani con il chiostro.
La piazza
La piazza e il complesso hanno assunto il loro aspetto attuale con i lavori di fine Quattrocento, a cui si sono aggiunti altri piccoli interventi nel XVI secolo. Prima di allora, lo spazio era probabilmente su due livelli.
S. Oliva ieri e oggi
Nel Medioevo la chiesa di S. Oliva ricopriva un ruolo fondamentale nella vita politica cittadina: è qui che i magistrati giuravano fedeltà allo statuto comunale, e sempre qui avvenivano le riunioni periodiche del Parlamento, composto dai capifamiglia di tutte le famiglie coresi.
Se volete rivederla come allora, venite il penultimo sabato di giugno, e troverete personaggi in costume che sfilano sul piazzale e giurano fedeltà allo statuto comunale: oggi come un tempo, infatti, qui si celebra il giuramento dei priori delle tre porte, nell’ambito del Carosello storico dei rioni.
Fonte: Scoprire Cori
TEMPIO D’ERCOLE
Da qualunque punto si guardi Cori, il tempio d’Ercole è il primo gioiello che attrae l’occhio: un tempio dorico che svetta sull’antica acropoli della città, con le sue colonne praticamente intatte.
L’architettura
Nell’89-80 a.C., quando è stato costruito, il tempio d’Ercole doveva essere uno spettacolo per gli occhi: in travertino, ricoperto di stucchi colorati, issato su un podio probabilmente rivestito di lastre di calcare, a cui si accedeva da una scalinata andata perduta. Monumento nazionale dal 1898, oggi se ne conservano soltanto il pronao e la parete d’ingresso della cella, che in origine doveva avere quattro lati chiusi.
Per la pianta, le caratteristiche delle colonne, dei capitelli e dell’architrave, il tempio d’Ercole è un perfetto esempio di uno stile dorico reinterpretato in chiave italica. Tra il 100 e l’80 a.C., infatti, si diffuse in Italia la pratica di ispirarsi ai modelli architettonici greci, rivedendoli secondo il gusto locale. Le colonne, alte 7 m, reggono un architrave che alterna triglifi (scanalati) e metope (lisce) in origine decorate con stucchi policromi. Notate in particolare i gocciolatoi a testa di leone. Sull’architrave della porta, un’iscrizione riporta i nomi dei due magistrati che curarono la costruzione dell’edificio, Marco Maglio e Lucio Turpilio.
I misteri
Rispetto al terrazzamento sottostante, il tempio d’Ercole è fuori centro: è il segno della probabile presenza di un’altra costruzione oggi distrutta, forse un tempio più antico. A questo apparterrebbero le terracotte figurate e le ceramiche votive del IV-II sec. a.C. esposte nel Museo della Città e del Territorio.
Da sempre, il tempio è noto come tempio d’Ercole, ma in realtà la sua attribuzione non è certa. Così lo chiamano i coresi da tempo immemore, in base a documenti che risalgono a ben prima del 1600 e a un’iscrizione del XVIII sec. considerata apocrifa.
Una musa per gli artisti
Quel che è certo è che nei secoli il tempio d’Ercole di Cori ha attirato un gran numero di studiosi, interessati alla sua peculiarità architettonica. Gian Battista Piranesi gli ha dedicato una serie di incisioni, che si sono rivelate importanti anche per ricostruire l’antica forma dell’edificio. Pare che perfino Raffaello sia venuto a misurarlo e immortalarlo in alcuni schizzi, quando fu nominato architetto della fabbrica di S. Pietro al posto di Bramante.
Il campanile
Il campanile dietro il tempio appartiene alla vecchia chiesa di S. Pietro, distrutta durante i bombardamenti del 1944.
Fonte: Scoprire Cori
Scopri gli altri monumenti di Cori su www.scoprirecori.it